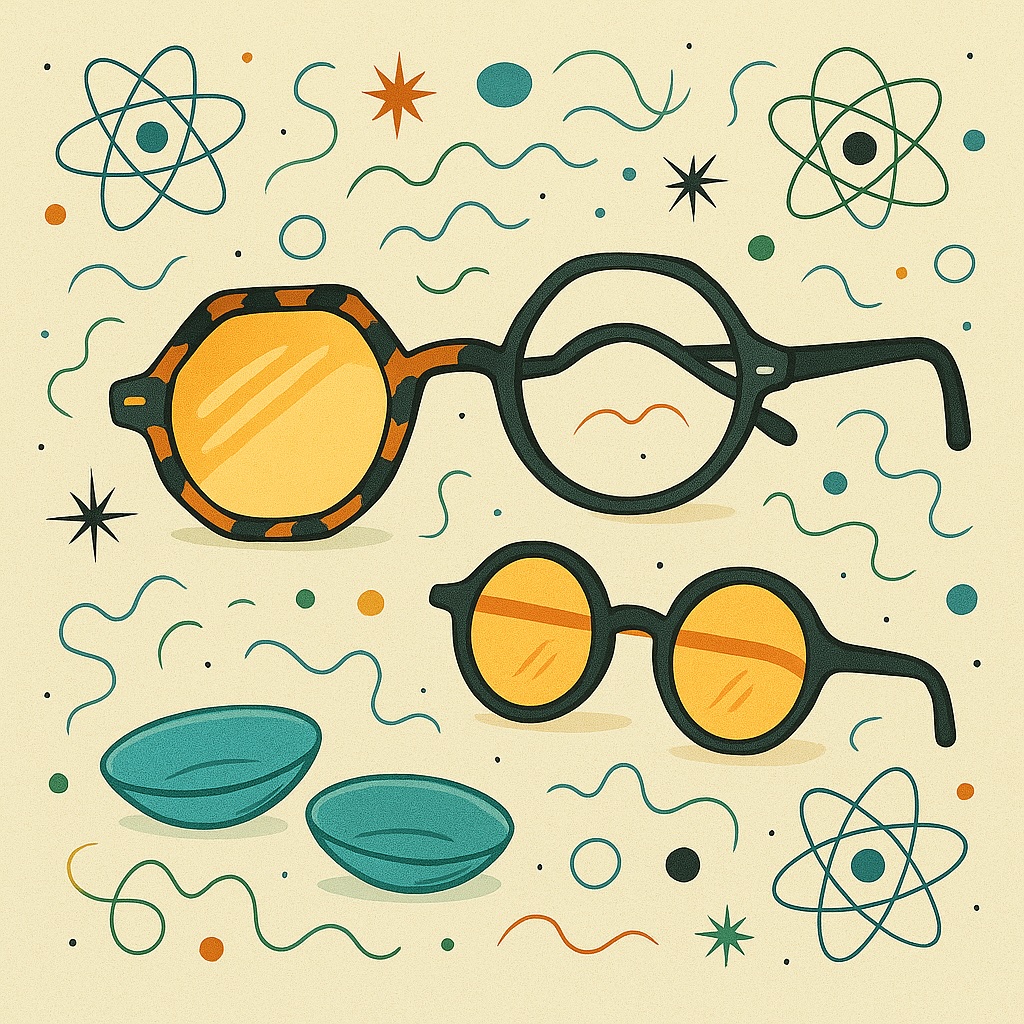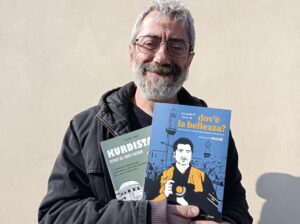Siamo materialisti. Abbiamo detto che questo è un punto fermo che ci posiziona agli antipodi di qualsiasi visione trascendentale per comprendere ed agire nella realtà.
Viaggiare attraverso la fisica/meccanica quantistica apre un tot di domande per chi vuole sfidare il presente.
Innovazioni, saperi, scoperte sono il prodotto della nostra intelligenza complessiva ingabbiata volente o nolente dalle logiche di potere e sfruttamento capitalistiche nell’era dell’Oltre umano.
Gli applicativi tecnologici di cui abbiamo parlato sono potenti, hanno una potenza intrinseca, che ci devono far riflettere su nuovi paradigmi della riproducibilità e dell’utilizzo comune.
Da un lato, ci sono cose che devono diventare riproducibili, accessibili a tutti: ognuno deve potersene appropriare, sia in termini di conoscenza sia di utilizzo.
Dall’altro, esistono cose talmente potenti che possiamo costruirle solo insieme. Queste non dovrebbero essere privatizzate a vantaggio di pochi, ma andrebbero socializzate, rese comuni anche nell’uso.
Non possiamo accontentarci delle convenzioni rituali che riducono il concetto di bene comune a “piccolo è bello” o lo legano unicamente a risorse e ambienti naturali.
Si tratta piuttosto di immaginare come superare quella sorta di timore che ci spinge a pensare che, se qualcosa è potente, allora appartiene necessariamente al capitale e non può essere gestita da noi.
Dovremmo invece saper immaginare lotte e percorsi per rivendicare la possibilità di accedere al massimo: che si tratti, a volte, della riproducibilità di un sapere o, in altri casi, della condivisione della forza trasformativa di una scoperta o di una tecnologia.
Perché non immaginare forme d’azione comune tra soggetti ibridi, nell’Oltre umano, per appropriarsi e rovesciare il senso dell’utilizzo di tecnologie potenti che oggi sono al servizio esclusivo del potere?
Se certamente non vogliamo lottare per avere ognuno un computer quantistico in casa, possiamo invece immaginare lotte radicali affinché il controllo e l’uso delle potenzialità del quantum computer appartengano alle comunità territoriali, alle forme di autogoverno e non siano lasciati unicamente alle logiche predatorie e di saccheggio delle grandi corporation.
Nell’ultima parte del dialogo con giovan3 fisic3 che frequentano l’Officina Scift inaugurata a marzo 2025 presso Labas a Bologna, con Giuseppe e Caterina parliamo a 360 gradi delle scienze tra presente e futuro.
La chiacchierata si articola in quattro parti.
Vi consigliamo di ascoltare gli audio per cogliere appieno la ricchezza di quanto ci è stato raccontato. Il testo scritto raccoglie solo alcune estrapolazioni, una sorta di riassunto essenziale accompagnato da brevi note.
Grazie a Giuseppe, Caterina e Marco e buon ascolto!
Quarta Parte
Nella parte conclusiva del nostro viaggio nella fisica e nella meccanica quantistica, proviamo ad allargare lo sguardo.
Siamo in un campo aperto: la ricerca avanza a ritmo sostenuto, c’è bisogno di approfondire molte questioni e, allo stesso tempo, è fondamentale condividere ciò che si elabora per poter realmente progredire.
Il sistema di potere contemporaneo si fonda su una costante tensione a mantenere il controllo sulle scienze. La frammentazione sempre più spinta e specialistica dei settori di ricerca — in cui operano come particelle isolate persone volutamente separate tra loro — e la scelta mirata su dove destinare i finanziamenti sono due leve che le corporation, le lobby finanziarie e gli attori statali utilizzano per massimizzare esclusivamente i propri profitti. Da dove si può partire per sovvertire questo scenario?
- Giuseppe
Credo che storicamente la scienza sia stata uno dei più grandi atti di ribellione dell’umanità ai pregiudizi e preconcetti.
Però era appannaggio solo di quei pochi che potevano permetterselo, nobili che magari non dovevano vivere di quello. Non si poteva vivere facendo semplicemente ricerca di base sui fondamenti dell’universo, sulle grandi domande, sui massimi sistemi.
Trovo molto intrigante in primis la matematica. Alle elementari ce la insegnano così: 2 + 3 = 5. Più in là si scopre che la matematica è anche un sovvertire le regole, perché magari esiste un sistema numerico in cui 2 + 3 non è = 5, ma torna indietro e fa 1. (Nota di Giuseppe: pensiamo anche solo a un orologio: se sono le 23 e aggiungo 3 ore, scavalco la mezzanotte e il display deve indicare 2, non 26. Queste considerazioni hanno dato luogo a un ambito della matematica che si chiama aritmetica modulare.)
La matematica ha una grossa componente immaginativa. Per le persone più giovani conoscere la matematica può essere un esercizio di liberazione della mente da preconcetti.
La fisica, le scienze in generale, ci dicono che proprio questi giochi di ribellione che operiamo nella nostra mente sono in grado di descrivere la realtà, la natura che ci circonda. Spesso la realtà supera perfino la nostra immaginazione per quanto è rivoluzionaria.
Quello che fa male della situazione attuale della ricerca è il non avere più la libertà di poter sperimentare, immaginare all’infuori degli schemi che i finanziamenti pubblici o privati mettono a disposizione. Si devono raggiungere tali risultati in tot tempo, si deve trovare un’applicazione tecnologica immediata. Chi non vuole sottostare a questo è messo in una competizione ferocissima per andare avanti, per fare un dottorato, per seguire una carriera accademica. All’interno di questo sistema capitalistico è veramente difficile, anche con il massimo dell’immaginazione, pensare a una ricerca veramente libera. Per cui faremmo meglio a rendere collettivi mezzi e conoscenze in un’ottica di condivisione, di visione di un’alternativa concreta a questo sistema.
- Caterina
La matematica è il linguaggio universale. Per definizione di base tutte le scienze che nascono dalla matematica, la fisica, le tecnologie per natura dovrebbero essere fruibili e fruite da tutti e da tutte allo stesso modo. Mi piace la citazione di Chiara Valerio che dice che la matematica è politica ed è una forma di democrazia, ci sono una serie di regole condivise e non c’è, non ci deve essere, il tiranno che prende le decisioni.
A livello di studi e di ricerche oggi c’è un problema perché la realtà si è distorta, piegata dalle logiche capitalistiche, che non sono quelle del contesto in cui nasce la matematica, la ricerca, la scienza. Il problema della fruibilità, della fattibilità della ricerca oggi si sente. Pesa il fatto che ci sia un pulviscolo di scienziati, non ci sia collaborazione, non si viva, non si senta la ricerca come cosa collettiva. Penso anche a tanti colleghi che fanno fatica a condividere le proprie ricerche o a chiedere aiuto ad altri enti di ricerca che stanno dall’altra parte del mondo. Viene meno il sentirsi comunità.
Per capirci pensiamo alla situazione che si crea quando magari siamo in quattro gatti a studiare una tal cosa, importantissima, ma che capiamo solo noi quattro e solo tre dei quattro sono interessati a studiarla veramente a fondo. Quello che succede è che viene meno la capacità di sentirla come qualcosa condiviso, un sapere collettivo e io faccio fatica a condividere le mie informazioni e a chiederti le tue informazioni.
Se penso la matematica come un linguaggio universale, penso anche che questa sorta di rete che si può creare tra persone che condividono le informazioni dovrebbe essere una cosa naturale. Questo atteggiamento è stato piegato dalle logiche del sistema che non lo rende più possibile oggi. Lo stesso sistema, quello in cui le grandi potenze -l’America da una parte, la Cina dall’altra- piegano il volere del mondo sotto le loro logiche, piega anche il singolo che al Gran Sasso sta portando avanti la propria ricerca sui neutrini.
Mai come oggi per confrontarsi con le sfide aperte in tutti i campi scientifici serve la multidisciplinarietà, l’ibridazione tra saperi diversi, la rottura delle categorie classiche di studio. Visto che un singolo non può essere onnisciente, la condivisione acquista un’importanza strategica. La multidisciplinarietà è presente nel campo scientifico?L’ho vista molto presente sia in ambiti più generici, dalla fisica alla biologia, alla medicina che all’interno della fisica stessa. Sto parlando della distinzione tra il fisico teorico e quello sperimentale. Due mondi completamente diversi che passano le giornate a studiare cose diverse o modalità diverse e poi alla fine trovano un punto d’incontro. Effettivamente la collaborazione tra questi due mondi apparentemente diversi c’è. E’ pur vero che siamo all’interno sempre della fisica e quindi non si può parlare effettivamente di multidisciplinarietà, però effettivamente c’è questa tendenza a mischiarsi l’uno con l’altro. Da un certo punto di vista lo si fa perché è necessario per il proprio lavoro interessarsi alle ricerche che fanno gli altri, ma questa tendenza sicuramente c’è.